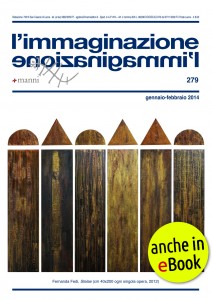Il romanzo A gran giornate di Claudio Morandini è, a detta dell’autore, un’avventura picaresca che si svolge in piena libertà, pur non potendo fare a meno di modelli letterari di riferimento, che vanno dal Satyricon di Petronio, con la sua struttura frammentaria, ai romanzi letti da bambino di Verne fino al Gordon Pym di Poe e alle Storie dell’anno mille di Malerba. Non mancano neppure influenze dei dialoghi surreali e grotteschi dei film di Bunuel. Il forte legame con la tradizione classica viene fuori anche dal titolo che è una citazione da Petrarca: “La vita fugge e non s’arresta un’hora / et la morte vien dietro a gran giornate”. L’intenzione è di rendere l’idea della vita dell’uomo, e dunque dei personaggi del romanzo, come di una corsa trafelata verso un baratro non ben definito; dietro c’è la morte che incalza, magnis itineribus. Il ricordo di Petrarca si combina con quello di Leopardi della Ginestra nella seconda parte dell’opera, quando tra i personaggi che hanno intrapreso un insensato viaggio verso una non ben definita meta si instaura un rapporto di solidarietà e di fratellanza per rendere meno gravosa la minaccia del nulla. La storia comincia in modo rassicurante, oscillando tra livello narrativo e metanarrativo: “Da dove cominciare questa storia?” si chiede l’io narrante. E di seguito precisa “Non dalla nascita, per favore.” Poi affida al lettore una trama fluida e affollata di personaggi che si presentano uno alla volta e cercano un loro itinerario. Sembra di trovarsi entro una macchina narrativa che ricorda la struttura dell’Orlando Furioso; non una trama lineare ma una combinazione di digressioni, di ellissi, di riprese, di ritorni indietro. Così scorrono i personaggi, uno alla volta, con un’ansia classificatoria da parte dell’autore che sembrerebbe contraddire il guazzabuglio del racconto complessivo e quell’impressione di non finito dato dai puntini di sospensione entro parentesi quadre […], che sigillano i capitoli. Onorato Casamagna è alle prese con la sua donna artificiale, di lattice, imbambolata dunque e priva di volontà e di parola, almeno nei primi tempi; Tullio Semenzani si rivela con un passato di galera e una vocazione al crimine; Nathan, il sacrestano, si dichiara avverso ai nudisti del campeggio “Dolci colline”, vicino al paese, e poi con un inspiegabile cambio di prospettiva improvvisamente favorevole; Franchino Spaventa per attirare l’attenzione dell’amata si è fatto biforcare la lingua; lo scrittore Angous, l’Uomo Malato, va a concludere i suoi giorni in una clinica di un luogo imprecisato, dove è l’amore passionale per l’infermiera Francine a segnare le tappe del suo ultimo viaggio; infine Ollsen è un personaggio enigmatico e originale, con il quale forse l’autore si identifica; sentendo il peso dei suoi quarantasette anni, riesce ad enumerare con crudezza e ironia i quarantasette segni di decadimento del suo corpo nudo davanti allo specchio. Questi tipi umani vivono sul filo di situazioni assurde e con la forza della loro inettitudine mostrano una corporalità e una carnalità che sconfina nel registro comico e grottesco. Anzi il lettore percepisce, a mano a mano che il racconto si sviluppa, una sorta di rovesciamento carnevalesco, di bachtiniana memoria, che conduce a un capovolgimento di valori e fa leggere tutte le storie per così dire dal basso o al contrario. Ma è un romanzo anche lirico, se si pensa ad alcuni simboli poetici che lo attraversano: si tratta di dettagli che si ingrandiscono a dismisura. Ad esempio la donna dal profilo di pesce che appare all’improvviso come un’epifania è una costante della storia e popola i sogni di alcuni personaggi. Da lei si sprigiona una forte carica metaforica, perché custodisce il mistero che si cela dentro il racconto. Il lettore si convince a non alzare il velame per non perdere l’incanto di un indecifrabile giuoco. Nella conclusione si capisce che quel simbolo è la chiave per sciogliere l’enigma, per comprendere cosa unisce tutte le storie e tutti i personaggi. Si ha l’impressione che si tratti di una guida salvifica, che alla fine del viaggio narrativo apra nuovi orizzonti. Una ridda di ipotesi si affastellano: “per uno è solo nuda roccia priva di vita, per un altro è un’insolita formazione di nubi, per un altro ancora è frutto di allucinazioni e delirio”. Ma sicuramente è un punto d’arrivo del viaggio verso cui tutti si dirigono. Nel finale si recupera l’infanzia che viene volutamente tagliata fuori nell’incipit, e proprio in virtù del simbolo mostruoso della donna-pesce, quasi da inferno dantesco: “Da bambino mi aspettavo sempre eventi definitivi: dietro ogni angolo un agguato, un pericolo in attesa, un mostro che trattiene il fiato. Era bello, rasserenante non trovarci mai niente, e muovere verso altri angoli con un po’di coraggio in più”. Così attraverso il sorriso rassicurante di un bambino che gioca con le proprie fantasticherie la storia si trasforma in una bella fiaba che non ha da essere decifrata.
(Elena Salibra, “L’immaginazione” n. 279, Manni, gennaio/febbraio 2014)